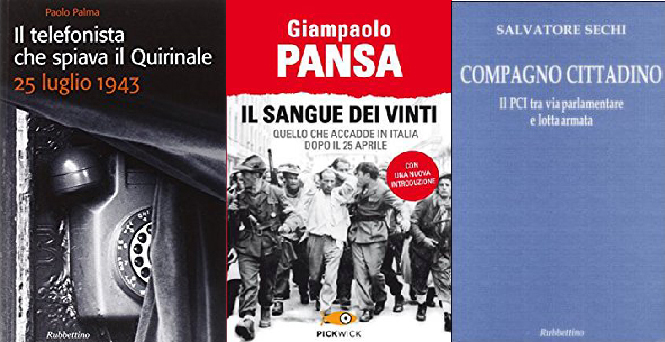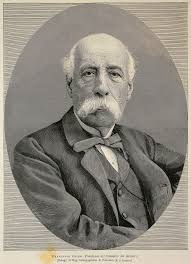«Erede diretta delle glorie dei violatori di porti che stupirono il mondo con le loro gesta nella prima guerra mondiale e dettero alla Marina italiana un primato finora ineguagliato, la Xa Flottiglia M.A.S. ha dimostrato che il seme gettato dagli eroi del passato ha fruttato buona messe»
Decima Flottiglia M.A.S., manifesto (50 x 82 cm, verticale)
Soldati Volontari e «banditi».
Ciò che è stato scritto in tempo di guerra, ovvero da chi era presente in quello specifico momento, ha un grande valore. Certamente quanto si propone è parte della propaganda della Decima, ma è altresì chiaro che costoro si sono presentati in prima persona Volontari, si sono battuti e molti sono morti.
Come si potrà leggere c’è chi non è morto per mano nemica, ma per mano di traditori che hanno tradito due volte: la prima perché sono passati al nemico, la seconda perché non hanno avuto il coraggio di battersi a viso aperto. Difatti, mai lo si dimentichi, costoro potevano agire perché non portavano divisa né, tantomeno, alcun segno di riconoscimento che li differenziasse a colpo d’occhio dalla popolazione civile in cui si mescolavano.
In questa parte si prosegue quanto cominciato nella XXII e XXIII parte, ovvero l’elencazione dei mezzi d’informazione della Xa Flottiglia M.A.S. Difatti Il Comandante Junio Valerio Borghese sa bene che la propaganda è fondamentale per poter fare affluire sempre nuovi volontari nei reparti e che, visto il clima interno in cui si dibatte la Nazione è fondamentale possedere i propri mezzi d’informazione: giornali, riviste e opuscoli.
Il Comandante Umberto Bardelli.
Opuscolo stampato il 28 luglio 1944 dalle Edizioni Erre, settimo di una serie di tredici. Composto da Mario Sanvito e R. C., ha 15 pagine di solo testo (12,5 x 17,4 cm) ed è composto da due articoli tratti da Il Pomeriggio del 13 luglio 1944 e da Regime Fascista del giorno seguente. La terza parte è la trascrizione, preceduta da breve commento, della lettera di Elena Zanga spedita a Serena Bardelli, figlia dello scomparso Comandante Bardelli, ucciso in imboscata a Ozegna da “parteggianti” armati (Mario Sanvito ed R. C., Il Comandante Umberto Bardelli, Decima Flottiglia M.A.S., Edizioni Erre, Milano 1944).
«Lettera a un bandito».
A proposito della vicenda occorsa al Comandante Umberto Bardelli e ai suoi Volontari, ecco la trascrizione di un chiarissimo documento di un Marò, Mario Tedeschi, pubblicato su Repubblica Fascista del 18 luglio 1944, che successivamente è divenuto un volantino fatto stampare dall’Ufficio Stampa della Decima Flottiglia M.A.S. di Milano, con sede in Piazzale Fiume n. 1. Il titolo è «Lettera a un bandito».
«Il marò allievo ufficiale del Battaglione “Barbarigo” Mario Tedeschi, catturato dai banditi ad Ozegna nell’imboscata in cui fu trucidato il comandante Bardelli con 9 suoi uomini e liberato poi, dopo 8 giorni di prigionia, ha scritto una lettera al capo della banda. Eccone il testo: // Credo, Piero, che non avrei accettato l’invito fattomi di scrivere quanto è passato in questi giorni dall’8 al 15, se al mio ritorno ad Ivrea non avessi veduto le fotografie dei miei compagni caduti nell’imboscata di Ozegna. Il viso sfigurato di Bardelli, morto da eroe; la sua bocca che le mani dei tuoi avevano lasciata spalancata dopo averne strappato i denti d’oro; la figura orrendamente deturpata del povero Fiaschi, ucciso con un colpo a bruciapelo nel cranio mentre già rantolava ferito; quei volti lordati oscenamente di fango; quelle divise lacerate dall’ansia del predone che frugava, hanno rinvigorito, se possibile, il risentimento dell’animo mio. Chi scrive queste righe, e lo riconoscerai dalla firma, è uno che ti ha dimostrato di non aver paura. Non sono quindi le ripetute minacce di morte, di arruolamento al «Battaglione San Pietro», come voi dite, che mi ispirano; ma è la ferita profonda lasciata nell’animo mio dall’aver veduto a quali punti di bassezza possono giungere gli Italiani. Lo slavo che alla sera dell’8, sulla piazza di Pont Canavese, ci prometteva di tagliarci prima il naso, poi le orecchie e, infine, il ventre, è molto superiore a voi che fingeste di trattare con Bardelli per far giungere i rinforzi e circondarci nella piazzetta della Chiesa, dove noi attendevamo con le armi scariche, fiduciosi della vostra parola. Venivamo dal fronte, dove avevamo combattuto non per un partito o per lo straniero, ma per l’Italia, così come voi stessi dite di fare: eppure furono degli Italiani che incolonnarono i 29 prigionieri per le vie di Pont Canavese, così come furono Italiani quelli che accompagnarono la sfilata percuotendoci e sputandoci in viso. È assai poco nobile, credimi, abbandonare all’odio e all’insulto stupido e bestiale di una popolazione accecata, dei soldati che hanno combattuto bene e si sono dovuti arrendere solo perché senza munizioni! Poi tentaste di convincerci a cambiar bandiera: e per sette giorni di fila fu un alternarsi di velate minacce e di botte propagandistiche; di menzogne sull’andamento delle guerra e sul comportamento dei nostri Comandi. Nessuno, del «Barbarigo», ha ceduto. Tu lo sai. Ma parliamo di voi, dei tuoi uomini, che qui si conoscono solo attraverso le voci di due propagande opposte. Il gruppo Piero è così composto: // 1) Una grandissima parte, formata per lo più di renitenti alla leva, che sta sui monti per paura di combattere; costoro, logicamente, non vanno in azione, ma sbrigano i servizi; 2) una parte risultante di individui che non possono scendere in pianura avendo commesso dei reati comuni nel periodo dal 25 luglio ad oggi; 3) una parte minima di individui che formano il nucleo combattente; parte in cui ho trovato qualche raro elemento che vorrei fosse con noi. La proporzione tra i combattenti e gli imboscati e dell’1 a 10. // A questo aggiungi che tutta la massa va avanti per forza d’inerzia, senza che sia possibile applicare una benché minima forma di disciplina. È stato un tuo amico che confessò ad uno di noi: «Se tentiamo di instaurare la disciplina qui restiamo in due». Questo gruppo di persone che financo nel vestire dimostrano la zingaresca essenza della cosa (ho visto uno dei vostri pavoneggiarsi di un berretto da gerarca fascista con su alcune penne rosse) vive distruggendo il patrimonio zootecnico della Valsassina, togliendo ai contadini burro e farina, prendendo (naturalmente in nome dell’Italia) tutto quello che vuole, ovunque lo trovi. E infatti vi vantate di non aver soldi in tasca, pur non mancando di nulla. Con simili combattenti mi diceste di voler rifare l’Italia, ma chiunque ragiona sa benissimo che la pace segnerà lo scioglimento improvviso dei reparti partigiani, dato che il 99% dei componenti altro non attende che quell’ora per tornare a casa, infischiandosene della situazione politica e dell’interesse nazionale. È evidente quindi che voi fate il gioco degli Inglesi, che voi proclamate di voler eliminare come i Tedeschi, e del Comitato di liberazione nazionale, composto di elementi più o meno bastardi che speculano sul momento. A rinforzare la cosa, noto infine che tutti i ribelli che ho incontrato vivono esclusivamente sulla propaganda di radio Londra, la quale li sorregge con menzogne che vengono tranquillamente bevute. Non fummo forse avvisati nel nostro periodo di prigionia che Londra aveva comunicato che Milano era stata violentemente bombardata e che uno sciopero generale era scoppiato a Genova, Milano e Torino? Allontanati da ogni contatto, i tuoi uomini guardano oggi con gli occhi che loro volle dare il nemico: credi, Piero, che questo sia bene per l’Italia? Non si deve forse proprio a questo la tremenda confusione di idee che ho notato fra voi, per cui combattete per Badoglio chiamandolo «bastardo»? Vi dite comunisti ossequiando i preti, vi chiamate liberi affidando il servizio viveri e il controllo dei rifornimenti ad un inglese, proclamate l’uguaglianza lasciando che il Comitato di liberazione vi abbandoni sui monti senza un soldo, appropriandosi dei vari chili di biglietti da mille lanciati dagli aerei, vi dite patrioti terrorizzando le innocue popolazioni con le requisizioni forzate e con i saccheggi. Questa l’impressione fotografica dei ribelli di Val Soana. Del periodo di prigionia non credo sia necessario parlare. È stato un alternarsi continuo di ansie e di calma, durante il quale siamo stati trattati con ipocrita cordialità. Il fatto che ci abbiate costretti in trenta in due stanzette, obbligati a lavare i vostri piatti, promessa ogni giorno la libertà, sono cose trascurabili di fronte al dolore provocato nel vedere quanto in basso sia caduta questa nostra Patria adorata. È per questo che noi, Piero, ci auguriamo di tornare presto al fronte. Ti sia ben chiaro però che mentre dall’imboscata di Ozegna tu non hai guadagnato che i pochi oggetti che avevamo indosso (ci toglieste persino la cinghia dei pantaloni) e il nostro denaro, noi abbiamo riportato il ricordo incancellabile della voce di Barbarigo che grida: «Barbarigo non si arrende! Fuoco!», additandoci così la via della vendetta e dell’onore. // Da Repubblica Fascista del 18-7-44» (già riportata in IV parte).
Un eroe della “X„ Leone Bogani.
Opuscolo stampato nel febbraio 1945 dalle Edizioni Erre, ottavo di una serie di tredici. Ha 22 pagine di solo testo (12,5 x 17,4 cm) ed è composto da più brani, il primo dei quali non reca né titolo né firma.
Sostanzialmente ricorda la cattura a tradimento e l’uccisione del Sotto Tenente di Vascello Leone Bogani a Torriggia, da parte dei soliti “parteggianti”, che non vestono divisa.
Seguono: leone bogani non è più… firmato in calce «Dal diario di un profugo, 28 Luglio - XXII»; uomini della “x” fra i banditi. “Tu mi fucilerai…” di Giulio Rossi e tratto da Sveglia! del 25 agosto 1944; Leone Bogani comanda il fuoco ai suoi assassini tratto da Regime Fascista del 2 agosto 1944. L’ultimo brano, senza titolo, è la lettera di un’amica che lo commemora tratta «Dal periodico “Ali„ del 3 settembre – XXII» (AA. VV., Un eroe della “X„ Leone Bogani, Decima Flottiglia M.A.S., Edizioni Erre, Milano 1945).
«Leone Bogani comanda il fuoco ai suoi assassini».
«decima flottiglia mas – reparto stampa // decima, a noi! // leone bogani comanda il fuoco ai suoi assassini». Questa è l’intestazione del volantino stampato fronte-retro a ricordo dell’episodio che deve rimanere fermamente inciso nella Storia d’Italia.
«Era un nostro amico. Quando, all’8 settembre, si compì l’ignominia d’Italia, egli non attese né un giorno né un’ora. Già tenente d’aviazione, non pensò al titolo di studio ed al grado e, come semplice milite, entrò nella Guardia della Rivoluzione. Poi tornò all’Aeronautica repubblicana, e in quei giorni oscuri di novembre vene da noi (felice di trovare nella redazione di Regime Fascista uno spirito «rivoluzionario e repubblicano»), perché qualcuno intervenisse a far cessare ogni magagna tipo… passato regime e perché gli fosse permesso di affrontare subito il nemico, invasore della sua patria adorata. Questo suo fuoco interiore, questa sua inesausta passione, lo fecero perfino tacciare d’indisciplina, tanto che egli preferì ed ottenne di passare alla Xa Mas, anche con la perdita di un grado, pur di trovarsi in mezzo a quei reparti che già contavano dei combattenti al fronte. E, nel marzo scorso, venne inviato alla scuola sommozzatori e ne uscì giorni fa, fierissimo, come pilota di mezzi d’assalto. I nostri lettori ricorderanno certo il suo nome fra i firmatari di una lettera che pubblicammo a fine giugno, lettera in cui il suo nobile ed altissimo patriottismo si ribadiva una volta ancora. Dal corso, in data 2 maggio, ci scriveva, fra l’altro: «Sto per terminare il corso che mi consacrerà pilota d’assalto. Figurati la mia gioia, dopo tanti mesi di ansiosissima attesa: potrò finalmente affrontare il nemico proprio sul mare, dove è cento volte più forte di noi! Ho tanto desiderio di venire a Cremona; voglio respirare una boccata d’aria veramente pura, come non se ne trova in nessun altro posto; un’aria che ha il magico potere di rinfrancare ed ogni tanto fa bene anche a chi di rinfrancamento non ha bisogno davvero…». Ed il 2 giugno successivo ancora: «… Ieri, in un incidente, abbiamo perduto il nostro comandante, tenente di vascello Domenico Mataluno, puro italiano e convinto fascista. Egli è caduto per insegnarci la manovra esatta per offendere, nel modo più fatale, il nemico. Era ottimo come comandante e come amico. È per noi una perdita gravissima; perché vicino a lui il mio cuore d’italiano palpitava più forte e più appassionatamente che mai. Il grave danno è che le persone migliori muoiono. È divinamente bello dare la vita per l’Italia, ma è anche divinamente bello poter godere, vivi e coscienti, l’attimo dell’immancabile vittoria. Qui noi facciamo continua propaganda e vediamo, con immensa gioia, che qualcuno non troppo fascista, di fronte alla infinita purezza del nostro entusiasmo, muta idea e viene a noi». Terminato il corso, Bogani, giovane ufficiale della classe 1920, fiorentino scanzonato, impulsivo, buono, audace, non ha che un desiderio: mettere a profitto contro le carene nemiche quanto ha appreso nelle dure lezioni pratiche, in tanti mesi. Ma, prima, chiede ai suoi superiori un breve permesso: l’odiato invasore avanza verso nord e la Toscana è minacciata. Già si combatte a sud della sua Firenze. Vuol correre a prendere la famiglia e portarla al sicuro dietro quel confine che la sua fantasia dà ancora per poco tempo alla Repubblica di Mussolini, in attesa del balzo della riscossa. «Voglio – egli dice partendo – che i miei vecchietti vedano sempre garrire il tricolore repubblicano e che possano leggere sui nostri giornali le mie… gesta». È partito ma non è tornato. Il sogno generoso del fanciullone è stato infranto non dall’acciaio e dal piombo del nemico, ma dalla cattiveria e dalla // malvagità di alcuni prezzolati traditori: sorpreso dai banditi presso Torriglia, mentre tornava al Corpo, si difendeva accanitamente per alcune ore, tenendo in scacco i fuorilegge col fuoco tempestivo del suo mitra e con le bombe a mano. Esauriti anche i sette colpi della pistola, era costretto ad arrendersi. Immediatamente giudicato colpevole di patriottismo, di fascismo e di difesa della divisa della Xa Mas, veniva condannato a morte all’unanimità. Che cuore possono avere queste belve, che non hanno sentito la grandezza di quel puro animo di ragazzo coraggioso ed entusiasta? Ma una via di salvezza c’è ancora per Bogani. Rinneghi il Fascismo, getti il distintivo, dichiari di non combattere più contro le bande e contro l’anglosassone e non gli verrà torto un capello. Salvarsi in questo modo equivarrebbe ad uccidersi spiritualmente; del resto, in Bogani, certi sentimenti non hanno mai generato crisi interne o dubbi di sorta: amare l’Italia, difenderla, morire per lei, erano postulati naturali per il suo spirito rettissimo. Il suo «no» è stato secco ed immediato. Ha chiesto un’unica grazia: poter scegliere un «muso non troppo brutto» che eseguisse la condanna e di poter comandare egli stesso il «fuoco». Quindi, il biondo eroe si accostò al muro, volse il viso verso l’arma spianata contro di lui, quasi a voler guardare in volto quella morte che uomini del suo medesimo sangue gli davano, si aperse la camicia sul petto e, nel silenzio assoluto di quel tragico momento, la sua voce si alzò limpida, sicura, squillante, come una diana di riscossa, quasi si trattasse di trascinare un plotone all’attacco: “Duce! Decima! Italia! Fuoco!”… Crivellato dal mitra di un venduto, il corpo del fanciullo Bogani cadde al suolo, mentre si ripeteva fra i colli il suo estremo saluto alla Patria amatissima. Leo, noi di Regime Fascista ti abbiamo ben conosciuto e tu resti uno dei nostri. Non è il momento di parole e di commemorazioni! Sappiamo che ti dispiacerebbe Ma ti promettiamo che sarai nel nostro cuore e che penseremo a te, intensamente, se la Patria non avrà voluto anche noi, il giorno magico, ineffabile della nostra vittoria. Ci dispiace soltanto che tu non abbia sentito il bollettino germanico di ieri: “In Italia, 8300 banditi uccisi e 7500 catturati”. Era dedicato a te!».
Cose Nostre S.A.F. Xa.
Voce del Servizio Ausiliario Femminile Decima, il giornale “Cose Nostre S.A.F. Xa” nasce con l’intento di essere pubblicato senza scadenza fissa e difatti in prima pagina reca scritto «esce quando esce». All’atto pratico, con ogni probabilità, dovrebbe essere l’unico numero uscito (1).
Il numero del 1° dicembre 1944 è composto da otto pagine e in fondo all’ultima colonna si può leggere: «Responsabile Vol. C.R. Fede Pocek / Stabil. Tipografico S.A.M.E. / Via Settala 22 - Milano» (Servizio Ausiliario Femminile Decima, Cose nostre, Comando S.A.F Xa M.A.S., 1 Dicembre, Milano 1944).
Si tratta di Fede Arnaud Pocek (Venezia 1921 – Roma 1997), iscritta al Partito Fascista, già responsabile del settore sportivo dei G.U.P. (Gruppi Universitari Fascisti), aderisce alla R.S.I. ed è arruolata dal Comandante Borghese in qualità di responsabile e guida del Servizio Ausiliario Femminile della Xa Flottiglia M.A.S. Nel sito Internet dell’Associazione Combattenti Xa Flottiglia MAS si legge: «Fede Arnaud era nella Xa Mas quando il 18 febbraio del ’44, a Cuneo, la banda partigiana di “Mauri” cattura il tenente di vascello Betti, il sottotenente di vascello Cencetti, il guardiamarina Federico Falangola e un marò, tutti del “Maestrale” che sta completando l’addestramento per trasferirsi – cambiando il nome in “Barbarigo” – sul fronte di Nettuno. Al comando è Umberto Bardelli che tenta di evitare lo scontro fratricida per liberare i suoi uomini: accetta la proposta di Fede Arnaud che sola, si avvia alla ricerca dei partigiani. Finalmente, in un paesetto di montagna, incontra una prostituta che accetta di accompagnarla in prossimità della loro base a condizione di non riferire la fonte dell'informazione. Localizzati i partigiani si fa catturare e condotta davanti al loro capo, esegue un perfetto saluto romano. L’uomo è Folco Lulli, un toscano sanguigno, buon attore cinematografico, che aveva lavorato con lei, allora giovane aiuto-regista, prima della guerra. Lulli non è comunista, apprezza il coraggio di Fede Arnaud, accetta il confronto delle opinioni e degli ideali e decide di rilasciare i quattro prigionieri perché raggiungano il fronte con i loro compagni» (http://www.associazionedecimaflottigliamas.it/servizio-ausiliario-femminile.html).
 Scrive Roberto
Scrive Roberto Roggero: «Proprio sul fronte di battaglia di Nettuno, con l’agguerrito battaglione “Barbarigo” della X MAS di Valerio Borghese, combattono anche le donne del gruppo “SAF Decima”. Un altro reparto femminile SAF combatte anche sulla costa baltica contro i russi, inserito nei battaglioni “Nebbiogeni”» (Roberto Roggero, Oneri e Onori. Le verità militari e politiche della guerra di Liberazione in Italia, Greco & Greco Editori, Milano 2006, p. 555).
Roggero: «Proprio sul fronte di battaglia di Nettuno, con l’agguerrito battaglione “Barbarigo” della X MAS di Valerio Borghese, combattono anche le donne del gruppo “SAF Decima”. Un altro reparto femminile SAF combatte anche sulla costa baltica contro i russi, inserito nei battaglioni “Nebbiogeni”» (Roberto Roggero, Oneri e Onori. Le verità militari e politiche della guerra di Liberazione in Italia, Greco & Greco Editori, Milano 2006, p. 555).
Colpisce un articolo, a pag. 3, perché è intitolato difendete la lira!, a firma tos; un brano è decisamente significativo: «Difendere la lira è difendere la fiducia nello Stato, è difendere la produzione nazionale, è difendere e valorizzare il lavoro (…). È auspicabile che presto, abbandonati i sorpassati principii di una moneta-merce fondata sull’oro, si accolga il criterio della stabilizzazione del potere d’acquisto, sulla base del reddito del lavoro. Si parlerà allora di detronizzazione dell’oro e di moneta sociale» (Servizio Ausiliario Femminile Decima, Cose nostre, Comando S.A.F Xa M.A.S., 1 Dicembre, Milano 1944, p. 3).

 Il brano rimanda, automaticamente, alla nazionalizzazione della Banca d’Italia, la quale è privata, nell’intento di toglierle il cosiddetto “diritto di signoraggio” statalizzandola.
Il brano rimanda, automaticamente, alla nazionalizzazione della Banca d’Italia, la quale è privata, nell’intento di toglierle il cosiddetto “diritto di signoraggio” statalizzandola.
Sulle imprese della Decima Flottiglia MAS si può consultare il sito dell’Associazione:
associazionedecimaflottigliamas.it
Note
1) Nel catalogo dell’ISEC è indicato come «Numero unico» (Marco Borghi, La stampa della RSI 1943-1945, Fondazione ISEC, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano 2006, p. 31).
Scrive Marino Perissinotto: «Nel marzo del 1944 nasceva con tutti i crismi dell’ufficialità il primo reparto militare femminile della storia d’Italia: il Servizio Ausiliario Femminile della Decima Flottiglia MAS, precedendo di pochi giorni la costituzione dell’analoga struttura organizzata dal Partito Fascista Repubblicano. Elitario ed autonomo, il SAF X^ formò con quattro corsi un numero limitato di volontarie. Donne in grigioverde, e donne marinaio, dunque. A costituirlo materialmente, ed a dirigerlo, fu Fede Arnaud, una giovane donna volitiva; ed il suo era un progetto, forse definito solo per linee di massima, che andava oltre alla guerra in corso, oltre al semplice vestire l’uniforme. Per dirla con parole dei nostri giorni, un “progetto donna”. A questo punto, non sorprenderà il lettore scoprire che le allieve della Scuola SAF si formavano attraverso assemblee aperte, che vi s’insegnava a svolgere qualsiasi mansione con pari dignità ed impegno, che si rifiutavano galloni ed onori. Più notevole il fatto che ad inventare questo Servizio Ausiliario furono donne giovanissime, poco più che ventenni; con risultati stimati ottimi anche dal fraterno rivale Servizio del Partito» (Marino Perissinotto, Il servizio ausiliario femminile della Decima Flottiglia MAS 1944-1945, Ermanno Albertelli Editore, Parma 2003, p. 9). Inoltre: «Negli ultimi giorni di guerra le Volontarie aggregate ai reparti del 1° Gruppo di Combattimento, in retroguardia durante la ritirata dal fronte del Senio, condivisero i rischi e le privazioni dei commilitoni maschi, ed anche la sorte di prigioniere delle forze armate alleate, che riconobbero loro lo status di militari» (Ibidem, p. 40).
N.B.: I bolli a corredo provengono da: Archivio di Stato di Milano; Tribunale Militare per la Marina in Milano (Repubblica Sociale Italiana), Procedimenti archiviati. Autorizzazione alla pubblicazione. Registro: AS-MI. Numero di protocollo: 2976/28.13.11/1. Data protocollazione: 29/05/2018. Segnatura: MiBACT|AS-MI|29/05/2018|0002976-P.
L'articolo DECIMA FLOTTIGLIA M.A.S.: propaganda per la riscossa (XXIV parte) – Gianluca Padovan proviene da EreticaMente.